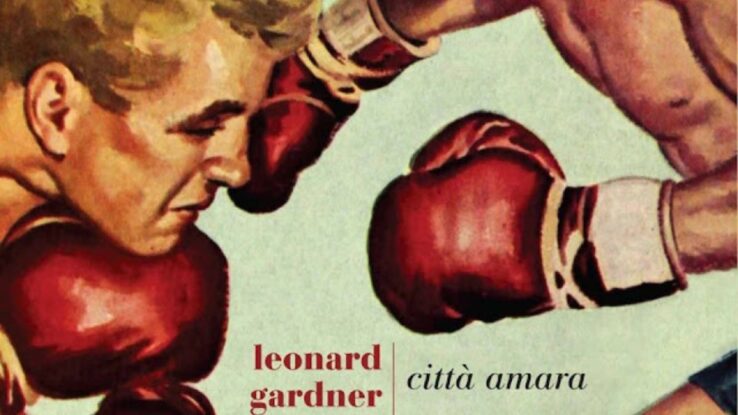Città amara (1969), di Leonard Gardner
Il pugilato è quello sport che, più di ogni altro, si sposa a meraviglia col cinema e con la letteratura, regalandoci picchi di drammaticità mai raggiunti da qualsiasi altra disciplina. In ogni ambito dell’immaginario collettivo, sacrificio, fatica, sofferenza e resilienza (termine che odio ma se non lo usi non sei nessuno) sono valori che si incastrano perfettamente come le tessere di un puzzle, regalandoci opere di assoluto valore. Il libro di Leonard Gardner non fa eccezione, così come l’omonima trasposizione cinematografica firmata John Huston, con protagonisti un giovanissimo Jeff Bridges e Stacy Keach. Tempo fa ho pubblicato questa recensione sul mio blog Il Cinenauta ed oggi ho pensato di riproporvela, per la sezione “NON SOLO BOTTE”. Buona lettura!
“Una specie di manuale del fallimento, in cui la boxe rappresenta l’attività naturale di uomini totalmente incapaci di comprendere la vita”. Sono le parole con cui Joyce Carol Oates, scrittrice contemporanea americana tra le più prolifiche e già cinque volte finalista al Premio Pulitzer, descrive l’opera di Robert Gardner. Un romanzo sulla boxe, quindi? Non proprio. O meglio: c’è il pugilato. Ma la noble art non è che un mezzo con cui l’autore s’intrufola nelle vite dei protagonisti, sviscerandone sogni, emozioni, desideri e rimpianti.
Città amara è l’altra medaglia dell’America che sogna. Quell’America della working class, più o meno hero, quella dei desideri infranti, delle speranze interrotte e dei trionfi che lasciano il posto alle sconfitte. Quell’America dove non c’è lieto fine e in cui la vita colpisce per prima e lo fa anche duramente. E quei protagonisti che tirano a campare alla meno peggio, cercando di sfangarla ogni santo giorno – ma precipitando, inevitabilmente, sempre più verso il fondo – è proprio attraverso la boxe che cercano il loro riscatto.
Billy Tully è un ex pugile che vive di ricordi, rimuginando su quello che poteva essere ma che non è stato. Ernie Munger, invece, è un ragazzo assai più giovane, che nella boxe intravede l’opportunità di una vita migliore. Uno è sconfitto dalla vita, mentre l’altro sembra essere lanciato verso un sicuro quanto effimero successo. I due si conoscono in una palestra dove lo stesso Billy, dall’alto della sua esperienza, “scopre” il più giovane. La città di Stockton, nel cuore della California, è il desolato scenario nel quale si muovono i due antieroi: palazzi per uffici, fast food, camini che sbuffano fumo, negozi di liquori e senza tetto buttati ai lati delle strade, sporche e piatte. Non c’è ombra di ricchezza né di successo nell’America dei perdenti. Le storie di Billy ed Ernie si sfiorano, s’intrecciano per un solo istante, proseguendo sempre su binari paralleli ma diretti verso un unico e amaro destino.
Ma allora dove sta la boxe? La risposta è: ovunque. Perché la boxe è lo sport più proletario che esista, così perfettamente a suo agio nel rappresentare quel Sogno Americano che vive di speranza, quasi fossimo in una ballata di Bruce Springsteen. La voglia di arrivare, partendo dal nulla. Ma la boxe è anche uno sport che può illudere e tradire. Ecco perché I due protagonisti si ritroveranno all’angolo, non di un ring ma in quello della vita. Città amara non è una glorificazione della sconfitta ma una narrazione, secca e asciutta, di vite miserabili e destinate al fallimento. E quell’atmosfera così soffocante e claustrofobica è ripresa magistralmente da John Huston nell’omonimo film del 1973. Billy Tully prende il volto di Stacy Keach (Classe 1999, Fuga da Los Angeles, American History X) ed Ernie Munger quello di un giovanissimo Jeff Bridges (King Kong, Tron, Il grande Lebowski). Un libro da leggere ed amare. Un film da vivere e di grande, grandissima fattura.